Time Has Come Today
Mookie intervista Lapo Gresleri, autore di «Body and Souls. Il corpo nero, #BlackLivesMatter e il cinema afrosurrealista»
«Piuttosto ho l'impressione che certi film vengano adorati perché consentono agli americani di credere che il problema del razzismo sia superabile semplicemente rievocando una mezza versione idillica della nostra Storia. Che sia tutta una questione di prossimità, o di un bisogno condiviso di risolvere un certo problema che è solo tangenzialmente connesso al razzismo». Le parole sono di Hanif Abdurraqib, prese in prestito dal suo ultimo libro, Piccolo diavolo in America. Abdurraqib dedica un intero capitolo a Green Book – in realtà più a Don Shirley e poi, di conseguenza, a Green Book –, film andato molto bene (uscì nel 2018), ma secondo diversi critici pieno di lacune e, soprattutto, alla fine troppo indulgente nei confronti dell’America bianca. Ma Green Book non è, anche per ovvie ragioni, un film espressamente “nero”, semmai un’edulcorata goccia nell’oceano di un movimento che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio fondamentale nell’ambito dell’industria culturale.
Tutte le forme d’arte – da quelle visive alla letteratura, dal cinema alla musica – stanno scandendo i tempi delle ingiustizie sociali ancora marcate, delle morti indegne e disumane, delle nuove consapevolezze. È successo per un paio di ragioni, in particolare: il razzismo “di ritorno” negli Stati Uniti che ha sgretolato la patina di un suo presunto superamento, da un lato; l’attenzione crescente verso alcune dinamiche – in larga misura dovuta ai più recenti avvenimenti, alcuni davvero sconvolgenti –, dall’altro. Al riguardo ne ho parlato con Lapo Gresleri, storico del cinema, collaboratore esterno della Cineteca di Bologna dal 2009 e autore di tanti saggi, articoli e recensioni. La sua ultima fatica è Body and Souls. Il corpo nero, #BlackLivesMatter e il cinema afrosurrealista (Bietti, 2021) in cui delinea i contorni di un cinema afroamericano contemporaneo – Lee Daniels, Dee Rees, Barry Jenkins, Ryan Coogler, Ava DuVernay e Jordan Peele tra i nomi di registi citati in apertura – sempre più maturo e carico di spunti, erede più o meno diretto – scrive Gresleri – dell’opera di Spike Lee, al quale nel 2018 aveva dedicato un altro volume: Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella società americana.
Quanto a Green Book, Abdurraqib conclude: «I film di questo tipo non affrontano mai l’idea più semplice e più franca: che il razzismo è un fatto di potere, e che per risolverlo ci sia bisogno, almeno in parte, di gente disposta a cedere il proprio potere».
Come di consueto, a Natale, Mookie esce con una puntata diversa dal solito. Lo scorso anno fu l’intervista a Carlo Babando, il 2020 fu una Christmas Edition con James Brown e i rapper della Death Row. Il colloquio con Lapo Gresleri, stavolta, nasce dalla curiosità di mettere a confronto due mondi – il cinema e la musica – che si sono sempre influenzati a vicenda, specie nell’ambito della black culture. Degli anni ‘70 e della blaxploitation, intrisa di sonorità soul e funk, abbiamo scritto spesso. E altrettanto abbiamo fatto con i film anni ‘90-primi 2000 in chiave hip hop. Oggi, tuttavia, stiamo assistendo a nuovi paradigmi, nuovi protagonisti e ad una coscienza rinnovata nel corpo e nello spirito. In altre parole ad un processo narrativo che si è evoluto, pur costretto a fare i conti – per tornare a Gresleri in Body and Souls – con «le grandi questioni irrisolte nel panorama statunitense».
Vale il consiglio del 2021: questa è una puntata speciale, perciò non dovrete leggerla per forza oggi, né scadrà nel giro di pochi giorni. È l’ultimo appuntamento dell’anno e ci ritroveremo quando sarà 2023. Nel frattempo, sono gradite condivisioni e passaparola: più siamo, più ci divertiamo. Buona lettura!
Ciao Lapo! Benvenuto e grazie di avere accettato l’invito di Mookie. Già dalle prime righe di Body and Souls, metti in luce come il nuovo cinema afroamericano sia «il punto di partenza per ampie riflessioni sul contesto multiculturale contemporaneo e le grandi questioni irrisolte nel panorama statunitense», in riferimento, cito ancora, «alla parentesi progressita della presidenza Obama» e «all’attenzione mediatica suscitata dai numerosi episodi di violenza e discriminazione razziale», fino al «neonazionalismo trumpiano». Ecco, partiamo da qui. Questo “salto” è avvenuto anche nella musica: Kendrick Lamar e J. Cole, Beyoncé e JAY-Z, più un incredibile sottobosco di artisti hip hop, soul, jazz e r’n’b, megafono delle «grandi questioni irrisolte» dell’America. Quali sono gli elementi più caratterizzanti della contemporanea ondata artistica che esamini nel tuo libro?
Il nuovo cinema afroamericano è salito alla ribalta in questi anni per la capacità innovatrice di trattare la problematica razziale nazionale proponendo un’alternativa alla visione tipicamente WASP (White Anglo-Saxon Protestant) del cinema hollywoodiano. Sono film di impianto spiccatamente realista e dai forti intenti sociali che tendono a ribaltare il canonico punto di vista esterno, portando lo spettatore a empatizzare ed identificarsi con chi vive soprusi e discriminazioni sulla propria pelle, invitandolo a prendere coscienza della questione e a cambiare la sua prospettiva in merito. Sfruttando stili e linguaggi tipici del cinema mainstream, il nuovo cinema black ne modifica assiomi e traiettorie narrative in forme che alimentano un immaginario collettivo più consapevole ed equilibrato. È quanto avviene, ad esempio, per Jordan Peele e Boots Riley, tra i primi autori a trasporre in immagini i principi dell’afrosurrealismo, una corrente trans- artistica che attraverso l’assurdo descrive la realtà nera contemporanea come talmente irrazionale da dover essere traslata nell’irreale. Opere come Scappa – Get Out, Noi, Nope o Sorry to Bother You fanno del racconto metaforico, eccessivo e iperbolico lo strumento per rappresentare situazioni concrete che rendono evidente quanto ancora è sommerso e taciuto dalla buona coscienza comune, in primis lo sfruttamento e il controllo sul corpo e le conseguenze che questo produce nell’afroamericano.
La centralità del corpo, evidente fin dal titolo, è uno spunto iniziale interessante. Parlare di corpo in relazione alla black culture significa parlare di numerosi aspetti, dai corpi straziati – gli “strani frutti” che cantava Billie Holiday, un esercizio di memoria collettiva capace di filtrare le esperienze, comprese quelle più traumatiche – ai corpi in mostra negli anni della blaxploitation, in una fase di orgoglio e di appropriazione di spazi definiti, con le seducenti sonorità soul e funk ad accompagnare questa rivoluzionaria esplorazione della sensualità nera. In che modo, invece, nel cinema afroamericano di oggi, la rappresentazione del corpo si è evoluta?
Il corpo nero non è più inteso nella sola accezione estetica rappresentata dai modelli hollywoodiani di Denzel Washington o Halle Berry, e ancora prima Sidney Poitier, Harry Belafonte o Dorothy Dandridge: corpi perfetti e molto vicini ai canoni della bellezza bianca da cui differivano solo per il colore della pelle, che però in loro poteva assumere una connotazione positiva e di ulteriore fascino. Il nuovo cinema afroamericano riflette la varietà dei tratti fisici e fisiognomici della popolazione nera, in un’accettazione e valorizzazione delle diversità singolari che trova le sue radici in quell’orgoglio nero alla base della black culture degli anni settanta. Ma il corpo assume anche una valenza simbolica. In tutti questi film, è attraverso e su di esso che l’afroamericano fa esperienza della propria alterità: ferito, vittimizzato, ma al contempo esaltato, si fa rappresentazione della resilienza nera, una resistenza all’ambiente circostante dettata dall’esperienza e dai fattori individuali. Il nero sì esperisce su di sé la propria natura, ma senza più vittimismi o vergogna, con l’orgoglio che nasce da una piena autocoscienza e conoscenza del proprio passato singolare e collettivo.
La famiglia e la figura della donna sono flussi di coscienza che caratterizzano, oserei dire da sempre, la narrazione dell’esperienza nera in America. È un turbinio di situazioni che si rinnovano di volta in volta. Non a caso hai dedicato ampio spazio a Jordan Peele per Us, film del 2019 che racchiude un po’ tutti questi elementi, sebbene in un contesto a tratti “folle”. Anche film più recenti, come A Jazzman’s Blues di Tyler Perry, rimarcano questo intreccio con protagoniste la famiglia e la donna (spesso madre single, moglie abbandonata o tutte e due le cose). Come si spiega, a tuo avviso, una trama di fondo così ricorrente? Più il segno di una rassegnazione corale o possiamo individuare dell’altro?
A mio avviso, l’identità nera nasce storicamente proprio all’interno del nucleo familiare o una comunità di poco più ampia. Fare gruppo è stato da sempre per l’afroamericano un atto rivoluzionario, di ribellione al padrone che preferiva tenere gli individui separati magari mettendoli uno contro l’altro, vedendo come pericolo un’eventuale coesione di intenti o di pensiero. Nelle famiglie la donna aveva un ruolo fondamentale: una figura che oltre a curare la casa (unica roccaforte in cui poter essere liberi), doveva farsi figura autorevole verso i figli, esempio non solo morale che faceva le veci del marito/padre quando assente o morto. Tale considerazione si è tramandata nei secoli fino ad oggi, dove però è inevitabile vedere dei cambiamenti all’orizzonte dettati da un’aggiornata concezione dei rapporti di genere. Pur sempre con maggior lentezza rispetto agli uomini, la donna nera sta raggiungendo lo stesso valore sociale e culturale, venendo spesso anche a invertirlo. È, certo, un processo lungo e faticoso, collegato anche a un immaginario collettivo che il nuovo cinema afroamericano sta cercando di scardinare proponendo nuovi modelli femminili che non siano però doppi di genere opposto delle loro controparti. Pensando anche al recente The Woman King di Gina Prince-Bythewood, è inevitabile riscontrare la volontà di affermare un’idea di donna autonoma e indipendente, capace di convogliare in sé gli aspetti valorosi e intrepidi dell’eroe con una sensibilità prettamente femminile che non è debolezza, ma umanità. Come dicevamo, la strada è lunga, ma è quella buona.
Per quanto le grandi questioni sociali – razzismo, inclusione, povertà… – siano dominanti nelle diverse declinazioni artistiche, negli ultimi anni Hollywood è stata accusata di essere troppo accomodante. È successo con Green Book – pur con tutti i distinguo del caso, non rientrando appieno nella nostra indagine –, ma persino con Judas and the Black Messiah e in generale con le pellicole tratte da storie vere. Il rimprovero è sempre lo stesso: gli eventi narrati subiscono una qualche forma di alterazione allo scopo di rendere i prodotti più digeribili all’America bianca. Poi ci sono altri aspetti, più legati alla forma. Per capirci: dialoghi come quelli presenti in Poetic Justice – film con Janet Jackson e Tupac Shakur del 1993 – oggi sarebbero meno tollerati. In questo senso la musica è forse riuscita a mantenere più intatte le sue radici.
Daltonismo etnico, colorwashing e politicamente corretto sono armi retoriche che da sempre tendono ad appiattire ogni discorso sotto una morale qualunquista che non fa distinzione alcuna della varietà culturale, sociale, etnica, ideologica del pubblico, presentando prodotti facilmente digeribili, ma che non soddisfano nessuno. Non è certo il cambiar colore alla Sirenetta o ribaltare il rapporto bianco-nero tipico dei buddy movies interrazziali a favorire una reale integrazione e il superamento di problematiche ad essa connesse. Però il cinema afroamericano, pur lavorando sui generi narrativi e quindi attenendosi ad essi e alle loro logiche, tendenzialmente sovverte l’atteggiamento accomodante che tu metti in evidenza. Bisogna però saper guardare oltre la forma e osservarne i contenuti, è lì la vera rivoluzione. Judas and the Black Messiah è esattamente questo: sotto la veste di film biografico sul leader delle Black Panthers, Fred Hampton, presenta un feroce atto d’accusa verso l’ordine bianco che a lungo ha contrastato il progresso nero di cui in parte si faceva promotore ostacolandolo volutamente. Viene in mente la risposta che Spike Lee riservava a chi criticava il suo Malcolm X di essere un film eccessivamente morbido: «Hanno creduto che sarebbero state tre ore e 21 minuti di Malcolm X che diceva che avrebbe bruciato tutti i bianchi sul rogo?». La questione è la stessa. Il problema è che troppo spesso lo spettatore è abituato a osservare passivamente quanto accade sullo schermo, senza porsi domande né fare attenzione a come una cosa è detta o rappresentata. Metafore e doppi sensi sono da sempre alla base del linguaggio afroamericano (pensiamo al singnifyin’ e al double talk), ma sotto quelle forme i contenuti sono ben diversi. Dobbiamo imparare a guardare in profondità le cose, andare oltre le apparenze.
Digressione doverosa, visto che lo hai citato e per l’apertura di credito che il suo lavoro ha spianato al cinema afroamericano a livello internazionale. Prima di Body and Souls, infatti, hai scritto un libro su Spike Lee, al quale, nel suo piccolo – come puoi immaginare dal nome che ho scelto –, questa newsletter deve molto. In particolare per Do The Right Thing, un film che già nel 1989 anticipò molto, in termini di relazioni interrazziali, di ciò che avremmo poi assistito su larga scala soltanto pochi anni dopo (penso alle rivolte di Los Angeles del ‘92). Quello che colpisce delle sue opere è la ciclicità degli eventi: Spike Lee non ha, o almeno sembra non avere, la presunzione di suggerire soluzioni, ma dimostra ogni volta come un determinato problema riemerga secondo nuovi modelli interpretativi. La conclusione di BlacKkKlansman è quella che forse può maggiormente dare un senso alla mia riflessione. Sei d’accordo con questa chiave di lettura?
Questo è uno degli aspetti più significativi del cinema di Spike Lee. Sin dal suo primo film, Joe’s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads, palesa il suo intento: trattare temi scomodi senza schierarsi mai aprioristicamente da una parte o dall’altra, mettendo in evidenza e in discussione limiti e atteggiamenti che ostacolano il raggiungimento di un’effettiva risoluzione. Ma questo senza la pedanteria e la saccenteria di chi ha tutte le risposte in tasca. Spike preferisce generare interesse e dibattito sulle tematiche affrontate, avviando un ragionamento con lo spettatore, ma lasciandolo libero di trarre le proprie conclusioni in merito. È un cinema estremamente maturo e intelligente che ancora oggi ha tanto da dire e insegnare. Certamente la ciclicità è evidente, ma è la Storia stessa a ripetersi se non si fa nulla per cambiarne il corso. Per Lee il presente non arriva mai dal niente: dietro c’è sempre un retaggio, un passato che va compreso e conosciuto. Da qui è necessario partire per andare veramente oltre.
Al pari di altri registi – su tutti mi viene in mente John Singleton, a proposito di Poetic Justice – la musica è un elemento fondamentale per Spike Lee, con la differenza che nel suo caso la colonna sonora è importante talvolta quanto il film stesso. Da profondo conoscitore e appassionato – di cui ci dà ampia dimostrazione nella serie Netflix She’s Gotta Have It –, usa la musica quale espediente ricco di significato: Fight The Power dei Public Enemy in Do The Right Thing è l’esempio più immediato, ma sono tutt’altro che trascurabili le due versioni dei Crooklyn Dodgers, rispettivamente per Crooklyn (1994) e Clockers (1995), a conferma dell’incastro delle sue opere con l’hip hop. E azzeccatissima, parere mio, è inoltre la scelta di Marvin Gaye in Da 5 Bloods. Di Mo’ Better Blues e Jungle Fever, la cui colonna sonora fu realizzata da Stevie Wonder, neanche a parlarne. Insomma, quanto aggiunge il rapporto che Spike Lee ha con la musica e quanto è utile nel suo disincantato racconto dell’America?
Che sia jazz, rap, soul, blues o più saltuariamente rock, la musica per Spike Lee è espressione della cultura (prevalentemente nera) americana, attraverso un gioco di botta e risposta con lo spettatore che – còlto o meno – genera un dialogo interno ai temi dei film. Lee attribuisce al commento musicale una funzione meta-narrativa, che dà vita a una serie di testi paralleli a quello filmico, venendone ad accentuare o rilevare messaggi e contenuti ampliando così le dinamiche stesse del racconto. La componente musicale dei suoi film non ha solo una piatta funzione empatica o emotiva, ma si sviluppa in profondità, facendone elemento centrale della scena, sua componente ritmica ed estetica oltre che veicolo di contenuti ulteriori di cui si fa portatrice in relazione alle immagini cui è associata.
Per concludere, una domanda scomoda, diciamo così, che rivolgo spesso agli ospiti di Mookie. Seppure con modalità differenti, capita a entrambi di occuparci di questioni legate a vicende americane e, più nello specifico, a vicende afroamericane. Si tratta di un lavoro analitico, ma ammetto di essermi chiesto qualche volta, presumo perché condizionato dagli infiniti dibattiti sul tema, con quale legittimità, vista con gli occhi di osservatore distante anni luce dalle realtà che mi sforzo di descrivere. Ti sei mai posto questa domanda? E soprattutto: che grado di interesse riscontri in Italia attorno a questi argomenti?
È inevitabile, un problema che penso tocchi tutti quelli che studiano una cultura diversa dalla propria. La stessa popolazione nera si è trovata a rapportarsi e confrontarsi con la cultura americana con la quale è entrata in contatto al tempo della schiavitù. Bisogna saper porre la giusta distanza tra sé e l’oggetto del proprio studio, uno sguardo profondo, ma al contempo distaccato che aiuti a penetrare la materia senza cadere in eccessi di supponenza o esaltazione. È l’annoso dilemma tra interesse culturale e appropriazione che da sempre caratterizza il rapporto tra la cultura nera e quella bianca statunitense: troppo spesso si tende a rileggere la prima attraverso la seconda e non come due percorsi distinti, ma intersecati. Si finisce così per uniformarle, appiattendole entrambe in una versione generica che non tiene conto delle specifiche peculiarità. È questo l’atteggiamento ancora molto diffuso in Italia, dove l’attenzione pubblica per l’argomento è aumentata notevolmente con il forte impatto mediatico provocato dall’omicidio di George Floyd e la conseguente ondata di proteste, ma il tema resta ancora di nicchia e spesso etichettato come una moda di scarsa presa sul pubblico. La storia, la cultura, la politica, in una parola l’esperienza nera, è conosciuta per sommi capi, tendendo a generalizzarla come quella americana. Quindi risulta difficile cogliere e comprendere appieno le numerose sfumature e profonde differenze della realtà afro-americana, dove quel trait d’union simboleggia proprio la duplicità del nero statunitense, quell’essere al contempo africano e americano, che racchiude il dramma e la specificità di un’etnia che ha partecipato alla creazione del Paese e del suo sogno, ma da cui continua regolarmente ad esserne marginalizzata se non esclusa. Una realtà che pur lontana si presta quale strumento di analisi e riflessione su problematiche analoghe che si presentano oggi – in scala inferiore – nei singoli scenari europei. C’è ancora tanto da fare in questa direzione, e da fare possibilmente assieme.
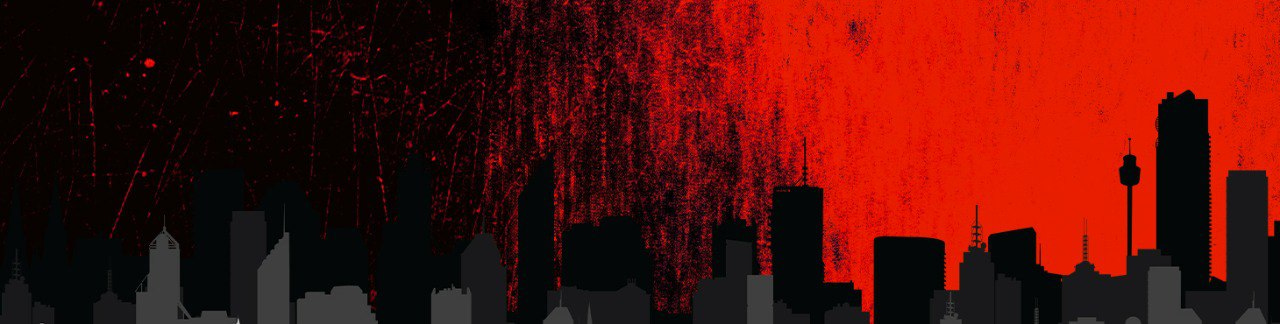
Ok, siamo giunti al termine dell’ultima puntata Venti-Ventidue, come dicono quelli. Torneremo a leggerci con il nuovo anno, ma non sarà un rientro rapido: il perché l’ho spiegato la scorsa settimana, dunque ci sarà da pazientare un po’. Durante l’attesa potrete recuperare qualcosa dall’archivio e poi non dimenticate la playlist di Mookie, per l’occasione aggiornata a tema Spike Lee (con Marvin Gaye, Public Enemy, Prince, Colonel Abrams e altri). Infine, c’è la chat della newsletter: funziona più o meno come un canale Telegram, ma è necessario scaricare l’app di Substack per accedere.
Domande? Suggerimenti? Potete rispondere alla mail, oppure scrivermi su Instagram, su Twitter o su Mastodon. Se Mookie vi piace, mandate il link alle amiche e agli amici!
Godetevi i giorni di festa, state bene e non esagerate con i dolci! A presto!





